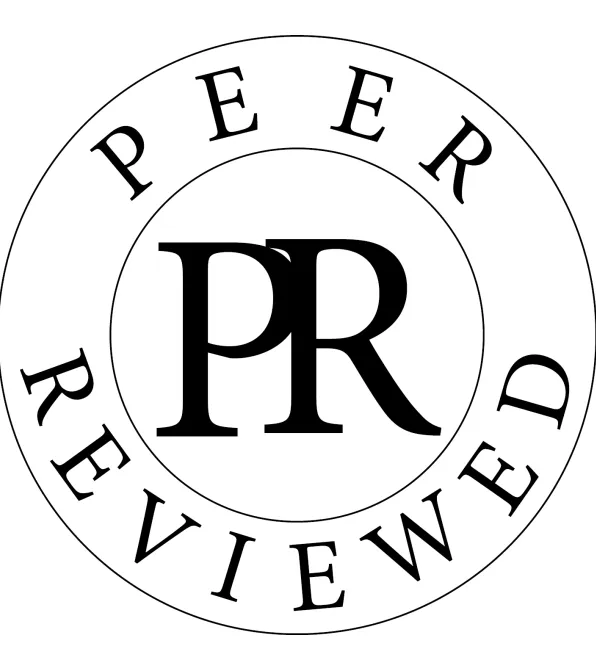Contro la feroce forza che fa nomarsi diritto. Verdi e il dispotismo: una proposta di lettura
Non è certo impresa facile cercare di riconoscere nell’opera di Giuseppe Verdi – pur così consistente, così ricca di riflessioni di vario ordine – un tratto apparentemente di secondo piano come il rapporto dell’artista col dispotismo. Eppure, cercando di portare l’indagine non solo entro il corpus verdiano, ma anche nella sua biografia, il dato della ripugnanza verso il dispotismo si pone, come dire, trasversalmente. Si è dinanzi, de facto, a un filo sottile ma (quasi) costante che – nuovo filo d’Arianna possibile – costituisce un aspetto di non poco momento, di là dalle principali, note istanze dell’estetica e della drammaturgia del Nostro. Onde condurre in tal maniera l’analisi, pare anzitutto necessario possedere un contesto affidabile, che chiarisca, fra il resto, cosa s’intende per dispotismo e che sgombri, nel contempo, il campo da inutili tentazioni cronologiche, aprendolo così a uno sguar... continua a leggere
torna su