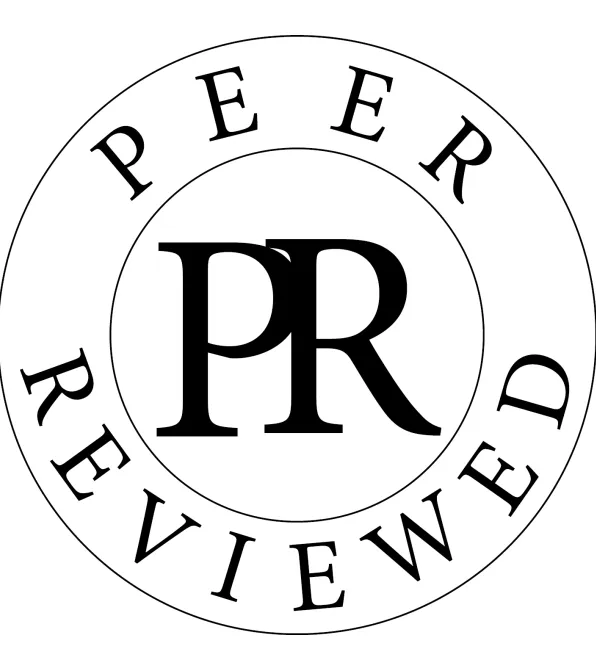Fari montaliani (e baudelairiani)

Matteo Veronesi, Fari montaliani (e baudelairiani), «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 58, no. 14, dicembre 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.12535
Muoveva tutta l’aria del crepuscolo a un fioco
occiduo palpebrare della traccia
che divide acqua e terra; ed il punto atono
del faro che baluginava sulla
roccia del Tino, cerula, tre volte
si dilatò e si spense in un altro oro.
(Vecchi versi)
E proprio in quel momento
brillò, si spense, ribrillò una luce
sull’opposta costiera. Già imbruniva.
– Anche il faro, lo vedi, intermittente,
forse troppo costoso tenerlo sempre acceso.
(Se al più si oppone il meno il risultato)
Basterebbe il raffronto fra i due passi appena citati (il primo dalle Occasioni, il secondo da Quaderno di quattro anni) per mettere in evidenza il contrasto, ben noto, fra il Montale lirico, alto, evocativo, talora volutamente sibillino, e quello prosastico, dimesso, diaristico, spesso, come in questo caso, autoironico, dell’ultima stagione; ma per far risaltare, in pari tempo, la sfumata e digradante continuità, fra l’uno e l’altro, di temi, motivi, immagini.
Nel primo dei due passi, il lampeggiare del faro è forse proustiana intermittence du coeur, possibilità di una rivelazione trapelante fra le tenebre, balenio d’epifania (il verbo baluginare ricorrerà, significativamente, spiraglio di una speranza nonostante tutto non ancora del tutto soffocata e sopita, nel Sogno del Prigioniero: «Questo che a notte balugina / nella calotta del mio pensiero, / traccia madreperlacea di lumaca / o smeriglio di vetro calpestato»).
Si sarebbe tentati di citare, per pura analogia, e magari anche per la tramatura fonosimbolica di liquide e rotanti ad evocare la vibrazione luminosa, Leopardi: «Già tace ogni sentiero, e pei balconi / rara traluce la notturna lampa»; e addirittura, attraverso di lui, il possibile sostrato dantesco, con lo stesso valore rivelativo, epifanico, se non salvifico: «da che Dio in te vuol che traluca / tanto sua grazia»; «s’altra cosa vostro amor seduce, / non è se non di quella alcun vestigio / … che quivi traluce»; la scala celeste «di color d’oro in che raggio traluce»; sennonché il contesto, in Leopardi, è quello di un’alterità, di una distanza, di una irrimediabile esclusione, più che di una vagheggiata o intravista salvazione.
Quasi superfluo, poi, a proposito di quel remoto lampeggiare, il richiamo a Bergson, in specie a quello (discepolo e insieme incauto antagonista, infine rinnegante se stesso, di Einstein) di Durée et simultanéité: il rapidissimo segnale luminoso, con la sua illusoria perfetta simultaneità, la sua parvente coincidenza d’istante d’emissione e istante di ricezione, sembra comprimere e vanificare lo spazio e il tempo, contrarre il fluire del tempo fino a far calare in esso uno spiraglio d’eternità: sensazione, questa, che esiste nell’immediatezza dell’esperienza sensibile, ma è impietosamente smentita dalla razionalità fisico-matematica. «En dénommant succession ce que j’appelais simultanéité, j’aurais un monde incohérent». Due eventi simultanei per un osservatore saranno in diverso rapporto per infiniti possibili altri. «Ce Temps, qui était à la fois ligne de lumière et durée, n’est plus que ligne de lumière». Basterà, s’illudeva Bergson, convertire i diversi sistemi di riferimento degli osservatori in altrettanti diversi fasci di luce perché la pluralità dei tempi sia ricondotta e riconciliata entro l’alveo dell’unico, immenso Tempo vissuto.
Ma proprio questa pluralità di ottiche (e d’identità), dilatantesi virtualmente sino all’infinito (o ad una molteplicità d’infiniti), è tipica dell’universo montaliano. «… e qualcosa che va e tropp’altro che / non passerà la cruna… / Occorrono troppe vite per farne una». «In me i tanti sono uno anche se appaiono / Moltiplicati dagli specchi. Il male / È che l’uccello preso nel paretaio / Non sa se lui sia lui o uno dei troppi / Suoi duplicati». (Anche qui, forse, la lieve autoriduzione ironica dalle Occasioni a Satura).
Epifania, si è detto (e segnalo, al riguardo, il bello studio di Adele Bardazzi, «Occasioni» e «moments of being»: il modernismo di Montale, Italianistica Debreceniensis, 23, 21-37, 2017, a cui andrà accostato quello di Tiziana De Rogatis, «Montale e l’epifania», Allegoria, n.62).
Difficile non pensare, per i versi montaliani, e in particolare per il preciso dettaglio del triplice lampeggiare del faro, a un passo di To the lighthouse di Virginia Woolf:
«And there rose to her lips always some exclamation of triumph over life when things came together in this peace, this rest, this eternity; and pausing there she looked out to meet that stroke of the Lighthouse, the long steady stroke, the last of the three, which was her stroke, for watching them in this mood always at this hour one could not help attaching oneself to one thing especially of the things one saw; and this thing, the long steady stroke, was her stroke. Often she found herself sitting and looking, sitting and looking, with her work in her hands until she became the thing she looked at – that light for example».
Il triplice balenio della luce esemplifica perfettamente l’essenza dell’epifania, la condensazione spazio-temporale in cui soggetto ed oggetto, conoscente e conosciuto sembrano fondersi; e in cui si rapprendono, eterni eppure subitanei, lampeggianti eppure come da sempre e perpetuamente effigiati, ricordi sensi pensieri che attendevano di essere liberati, in una molteplice raggiera, dalla materia inerte del vissuto.
Siamo insomma a contatto con quella che Montale chiama altrove, sempre associandola ad un lampo di luce, «eternità d’istante» («il lampo che candisce / alberi e muro e li sorprende in quella / eternità d’istante – marmo manna / e distruzione – ch’entro te scolpita / porti per tua condanna e che ti lega / più che l’amore a me, strana sorella»), e che può forse essere vista come una rilettura tutta soggettiva, tutta umana e terrena, della cristiana plenitudo temporum, quasi una fragile e precaria prefigurazione della salvezza.
Si può citare, sempre per analogia (anche marina), la lampada che è, per Pascoli, la poesia: «La barca / che, alzando il fanal di fortuna, / nel mare dell’essere varca, / si dondola, e geme» (dove si agglutinano, in modo quintessenziale, due antecedenti danteschi, quello del «legno che cantando varca» e quello, onto-teologico, del pelagus Substantiae infinitum, del «gran mar de l’essere» nel quale le nature «si muovono a diversi porti»).
E al mare come simbolo dell’Essere, dell’Eterno, e forse di un pascaliano, leopardiano o heideggeriano Infinito-Nulla, riporta ancora Montale, quello di Mediterraneo, il mare «vasto e diverso / e insieme fisso», in cui resta confuso, e di fronte a cui si nullifica, il minuto e fioco «fermento» del poeta.
E, allora, il faro letterale di Montale non sarà troppo distante dai metaforici Phares di Baudelaire: le cui figurazioni (evocate nel testo non con riferimenti iconografici precisi, ma con indeterminate, allusive e del tutto soggettive analogie: perfetto esempio di critica in versi risolta in pura forma d’arte) sono del resto, esse stesse, epifanie ante litteram.
Il substratum, il common ground metaforico che unisce incipit e chiusa del testo è proprio il mare: nei quadri di Rubens «la vie afflue et s’agite sans cesse, / Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer»; e l’immagine finale è quella di un «ardent sanglot qui roule d’âge en âge / Et vient mourir au bord de votre éternité»: dove la riva dell’eterno è quella di un metaforico, o forse allegorico, mare.
«C’est un cri répété par mille sentinelles / Un ordre renvoyé par mille porte-voix; / C’est un phare allumé sur mille citadelles». Pare per inciso possibile, benché omesso dai commenti, il richiamo a Lucrezio, e alla sua lampada della vita che passa di mano in mano, di generazione in generazione («Inque brevi spatio mutantur saecla animantum / Et quasi cursores vitai lampada tradunt»), pur se sempre destinata alla disgregazione in quegli elementa e primordia che sono costituenti primi, e ultime disperse vestigia, tanto delle creature quanto delle parole, tanto della vita quanto del linguaggio.
In riva al Mare del Tempo e dell’Eterno (fosse pure quello della Bellezza) si viene per morire. In quel fecondissimo vuoto, in quello sterminato Nulla deve infine perdersi ogni balenante e labile epifania. È forse invano che ogni faro rischiara le tenebre.
Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2024 Matteo Veronesi